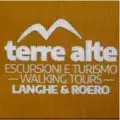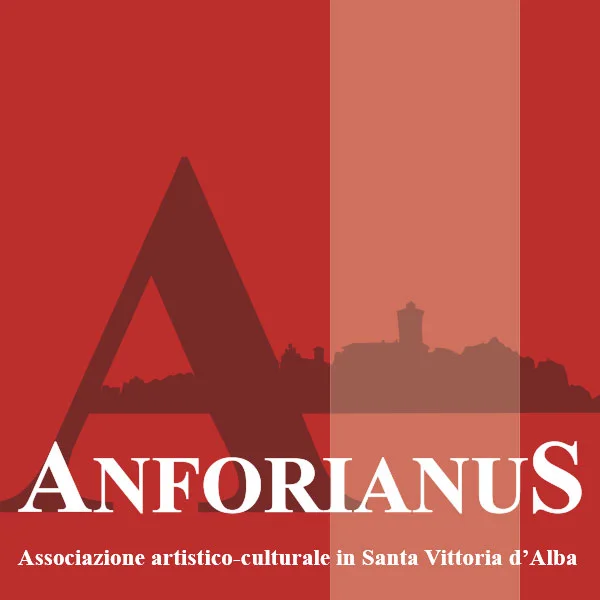l'arte e il territorio

sono per tutti

Storia Arte Musica Natura
Scopri l'associazione
Custodi della storia, attivi nel presente
Come un’anfora che conserva tesori, vogliamo preservare e condividere la ricchezza culturale, aprendo al pubblico siti storico-artistici del nostro paese.
Gestiamo diversi siti culturali della nostra città e organizziamo eventi per avvicinare cittadini, giovani o anche semplici curiosi alla riscoperta del patrimonio locale.
Scopri i luoghi di interesse
Le meraviglie di Santa Vittoria d'Alba
Scopri gli aggiornamentiGli eventi e
Gli eventi e
le novità
Un piccolo paese con una grande anima: a Santa Vittoria d’Alba potrai scoprire degli scrigni di cultura e bellezza inaspettati e partecipare ad eventi unici incorniciati da panorami mozzafiato.
Resta aggiornato sulle novità!
Resta aggiornato sulle novità!
Scopri la storia
Le origini di Santa Vittoria d'Alba
Una città con antiche radici con un fascino tutto da scoprire
I nostri partner

Comune di Santa Vittoria d’Alba

Corino

Azienda agricola Cornaglia – Cournaya

Azienda Agricola Fratelli Rabino
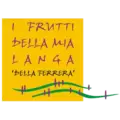
I frutti della mia langa

Ferramenta Messa S.n.c.
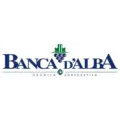
Banca d’Alba

BPER Banca
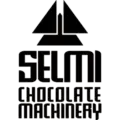
Selmi S.p.a.

Raicar Service

Pro-loco di Santa Vittoria d’alba

Biblioteca di santa Vittoria d’Alba

Langhe Monferrato Roero-Visit LMR

Fratelli Dellavalle

Il Gottino

Sartore

Serigraphis

Valdispinso
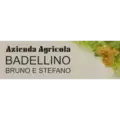
Azienda Agricola Badellino

Cavalieri di San Michele del Roero

MUDI

Alba Bra Langhe Roero- Capitale della Cultura

Roero Coast to Coast

Creativamente Roero

Ecomuseo delle Rocche

Sentieri dei Frescanti